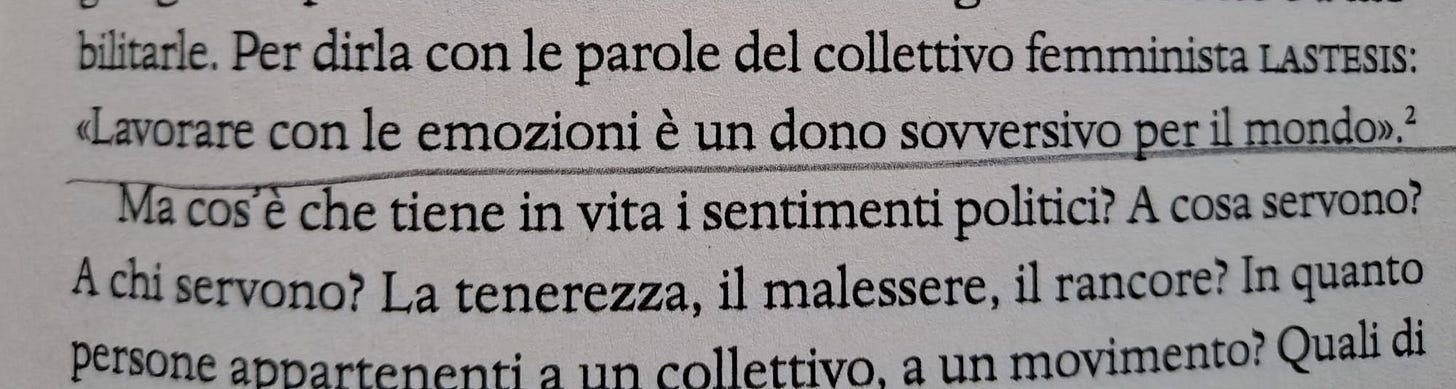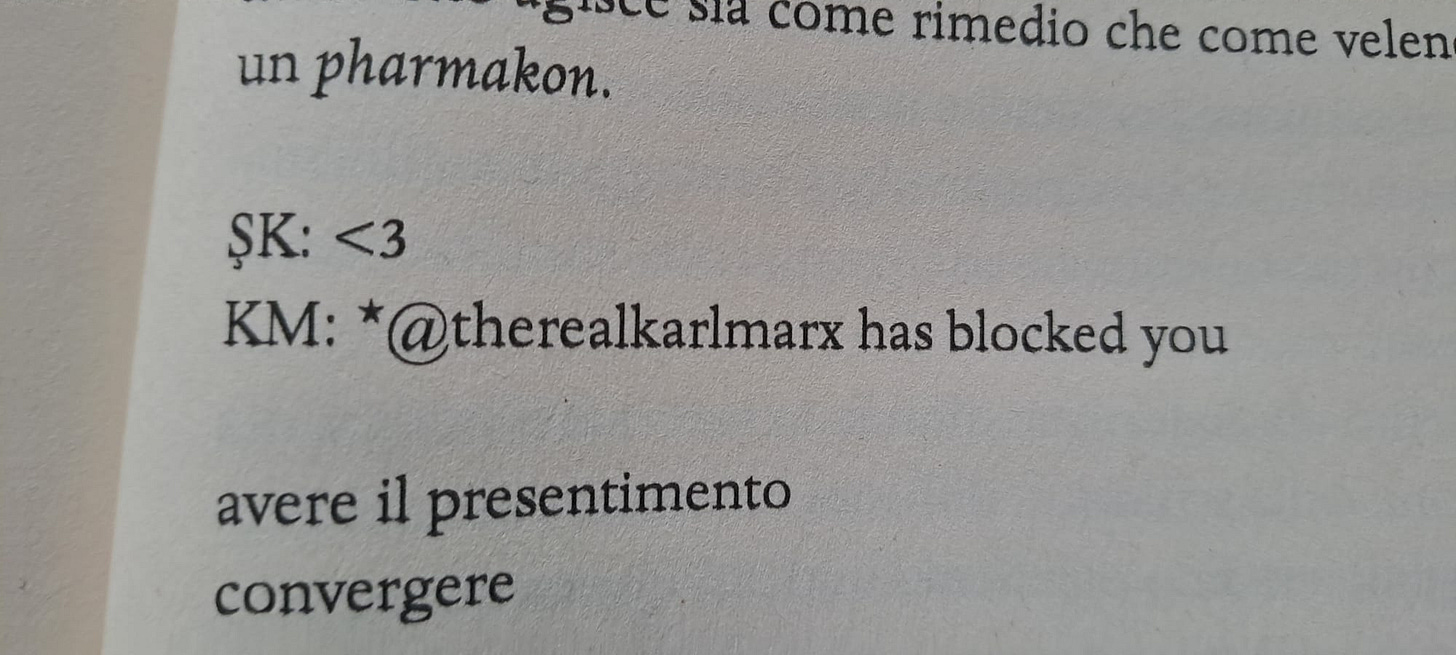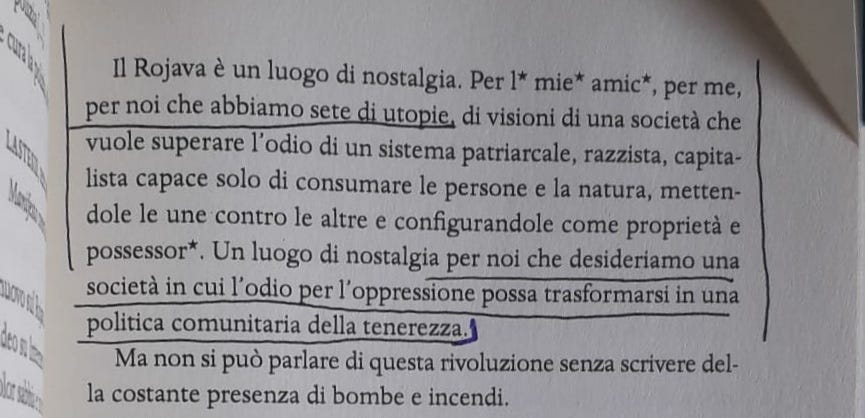Emozioni resistenti. L'odio secondo Şeyda Kurt
Conversazione con Rachele Cinerari, traduttrice di "Odio. Il potere della resistenza" di Şeyda Kurt
Qualche tempo fa, Lorenzo Ciarrocchi e Fabio Ciancone mi hanno intervistata per Instabile, un podcast di interviste sulla precarietà, sui temi de La trama alternativa. Nel corso della puntata gli autori hanno citato un libro recentemente tradotto per minimum fax, Odio. Il potere della resistenza di Şeyda Kurt, per via di alcune questioni che risuonavano in entrambi i libri. Io non avevo avuto ancora l’occasione di leggerlo, mentre Lorenzo e Fabio qualche mese prima avevano intervistato Rachele Cinerari, editor freelance, ricercatrice post-doc in teoria della letteratura e traduttrice di Şeyda Kurt. Così, a metà marzo, ho chiesto anche io a Rachele di fare due chiacchiere insieme. Impossibile riportare tutti gli spunti, arrivati anche dopo, ma ecco alcune tracce di questo dialogo:
Giusi: Rachele, dopo l’intervista con Instabile, sono emersi punti di contatto tra i temi della Trama alternativa e Odio. Il potere della resistenza di Şeyda Kurt. Ti va innanzitutto di parlare delle ragioni dietro la scelta di tradurre questo libro?
Rachele: C’è da dire che io non avevo pensato a questo libro, ma al precedente di Şeyda Kurt uscito nel 2021 e intitolato Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist, (Tenerezza radicale. Perché l'amore è politico), che racconta di come l'amore possa essere politicizzato e di come le relazioni intime e affettive, abbiano molto a che vedere con il contesto sociale e culturale in cui si sviluppano.
Secondo Alice Spano – in quel momento editor per minimum fax – , in Italia stavano uscendo già diversi libri importanti su questo argomento e lei propose l’ultimo in uscita. Odio. Il potere della resistenza è una sorta di specchio di Tenerezza radicale, e parte dal presupposto che in Germania, e in generale nel mondo, si parli molto dell'odio delle destre, dell'odio di chi ha il potere, di chi questo potere lo esercita sulle persone oppresse e subalterne, ma non abbastanza dell'odio delle comunità marginalizzate, di cos'è questo tipo odio, di come funziona, del peso che ha, delle direzioni che prende. Ci abbiamo riflettuto un po', io non ero convintissima, perché tra odio e tenerezza tifo sempre tenerezza, poi ho letto il libro e mi sono accorta che Kurt scrive di un odio che produce tenerezza, quindi mi sono convinta della proposta. Inoltre, ci ho trovato un po' di questioni che mi giravano in testa, e che si collegavano ad altri libri che stavo leggendo, tra cui il tuo, e mi è sembrato di riconoscere delle connessioni.
Giusi - È bello che parli di un odio che produce tenerezza. Da varie prospettive stiamo ragionando sulle origini dell’odio, ma quasi mai parliamo di quello che può produrre, di ciò che viene dopo. Nello spazio mainstream, l’odio delle classi oppresse viene sminuito o invisibilizzato, viene raccontato male o strumentalizzato, ed esiste solo nel momento della sua esplosione sensazionale. Di sicuro facciamo ancora fatica a evidenziare il fatto che quest'odio è mosso da amore… lo dicevano una volta i 99 Posse! Cosa ne può venire quando non viene criminalizzato o liquidato come qualcosa di irricevibile?
Nella lettura, ho provato a seguire questa sistematizzazione dei tipi di odio, e mi ha colpito quando Kurt menziona l’odio impossibile, quello che esiste ma non si riesce a esprimere, l’odio che deve essere disinnescato per poter funzionare (a volte sopravvivere) in una relazione di subalternità o di oppressione: non a tutte le persone, infatti, è concesso di mostrare odio senza subire conseguenze. Soprattutto perché il soggetto oppresso quando esprime odio nello spazio pubblico, perde immediatamente lo status di vittima perfetta, necessario per ottenere un minimo di attenzione e di compassione. Il tipo di comportamento accettabile in Europa, come dice Kurt, è il risultato dalla narrazione colonialista, bianca, borghese e cattolica: l’odio delle classi oppresse, allora, va soppresso, giudicato male o si tenta di convertirlo in un vago e neutro perdono, a volte tutte queste cose insieme. Talvolta nel lavoro coi gruppi mi capita di toccare il tema della comunicazione non violenta, che in questi anni è diventato uno degli strumenti più famosi nei workshop per attuare un dialogo costruttivo. Qui parlo dunque da facilitatrice con un approccio preciso: per me è uno strumento che in certi contesti può essere utile, ma è importante restituirgli una profondità e una prospettiva intersezionale. E i motivi sono proprio le domande che pone Kurt: in un contesto facilitato, e auspicabilmente in molti altri contesti del quotidiano, nelle ordinarie interazioni, spesso anche tra persone con gli stessi ideali di giustizia sociale, dovremmo essere capaci di dire: perché odia questa persona, perché sta usando un linguaggio aggressivo, irragionevole, inaccettabile per la lettura dominante?
Rachele - Sì, queste domande mi risuonavano molto quando ho letto il libro la prima volta: chi odia perché odia? E, soprattutto, in che dinamiche di potere e di oppressione si trova nel momento in cui questo odio viene fuori? Se penso alla mia esperienza personale, ma in generale anche nelle dinamiche relazionali nella quotidianità – che siano relazioni più intime o relazioni politiche, assemblee o relazioni professionali –, l'odio, la rabbia, che sono simili ma non sono la stessa cosa, vengono sempre e costantemente represse. Fin da bambine ci viene detto che se hai un atteggiamento che appare violento, “passi dalla parte del torto”.
Questa cosa Kurt la mette in relazione con un'altra modalità di odio, l'odio nei confronti di sé stessa, penso all’influenza dei canoni estetici e comportamentali occidentali. Nel corso dei secoli si è spesso associato l’odio – in maniera coloniale e classista – all’aspetto e al comportamento delle persone subalterne e le persone oppresse spesso arrivano a odiare sé stesse, per il tipo di reazione e relazione che l'oppressione genera.
L’idea dell’odio come sbagliato è talmente pervasiva che contamina ogni aspetto delle nostre vite, anche negli ambienti più politicizzati e radicali. Pare banale dirlo, ma pensiamo alle manifestazioni in piazza, le frange violente sono considerate quelle che rovinano la manifestazione, il clima quieto e pacifico della piazza.
È una cosa così pervasiva che si ritrova anche nei dialoghi tra persone politicizzate, nelle assemblee, nelle relazioni intime tra persone politicizzate, sembra che non se ne voglia parlare, ogni espressione che appare come odio viene repressa, agiamo dei meccanismi di negazione e disciplinamento anche nelle relazioni quotidiane e nelle relazioni intime.
Tra le cinque modalità dell’odio che elenca Kurt, l’impossibilità dell’odio sembra il tipo più subdolo, quello più difficile da portare come argomento di discussione. E oltre ogni tassonomia, che è sempre rivisitabile, a me sembra che Kurt racconti molto bene come si sia connotato l’odio nelle società occidentali. E penso che Kurt si sia trovat* a scrivere questo libro nel momento in cui le cose hanno iniziato un po' a sgretolarsi intorno a sé, nella società tedesca, ed è per questo che qui parla poco di tenerezza. È un libro molto collocato nella Germania contemporanea, riflessioni che non arrivano spesso in Italia.
Giusi - Hai ragione, difficilmente abbiamo una prospettiva europea su questo filone di investigazione della componente emotiva delle nostre educazioni politiche. Vengono tradotti pochissimi libri da altre lingue che non siano l’inglese e una traduzione dal tedesco da quel punto è sicuramente rara. In questi giorni, poi, in cui si parla di Europa, di senso di unità, di questo senso di appartenenza che dovremmo tirare fuori ignorando tutto il resto, spesso su basi vaghe e manipolatorie… Kurt cita i tanti motivi per cui l'odio esiste ai margini delle grandi città europee, come conseguenza di una violenza assolutamente silenziata. Parliamo dell’Europa che si ostina a imporre un’immagine falsata di se stessa, a dispetto di tutto il lavoro sul margine, sulla decolonialità e sulla bianchezza fatto da tante studiose e militanti in questi anni. Viviamo un’Europa in cui il potere si ostina a dire noi siamo bravi e buoni, abbiamo dei difetti tutto sommato trascurabili, ma in fondo va tutto bene. Voi, invece, che portate questo odio, perché volete rovinare tutto?
La tenerezza, Kurt la cita facendosi la domanda «tenerezza fino a che punto, tenerezza per chi?» E mi fa venire in mente una frase a cui sono molto affezionata, in inglese, non so esattamente quale possa essere una traduzione altrettanto efficace in italiano, che è disturb the comfortable e comfort the disturbed. Cito un dato personale che tanto personale non è: tra le persone con cui faccio politica, spesso persone amiche, esiste in molti momenti questa tenerezza diffusa nelle dinamiche, nei più microscopici dettagli. E la questione che più mi muove non è l’odio che condividiamo verso le classi dominanti, verso l’abuso di potere, che dalla nostra prospettiva mi pare un po’ scontato, ma è proprio il fatto che in tanta devastazione siamo riuscit* a preservare questa tenerezza, in certi casi strappandocela, inventandola da zero, percorrendo la direzione ostinata e contraria alle disfunzioni del capitalismo, della società, delle famiglie, etc, e, nonostante a volte vada a vuoto, questo tentativo di costruire altro mi pare una enormità che va celebrata più spesso.
Esiste uno strumento che uso, che per praticità classifica i tipi di conflitti, e parla di questo tipo che è il conflitto accomodante: c'è una persona, un elemento, un attore del conflitto che reprime i suoi sentimenti, i suoi bisogni, per dire ok, non è successo niente, va tutto bene, perché vuole evitare di scatenare l’ira dall’altra parte. La discussione aperta forse si evita, ma il conflitto continua a esistere, questo accade perché spesso esporsi all’ira di chi ha più potere può voler dire mettere a rischio la propria incolumità, ma non solo e non sempre. Appartiene anche a un certo modo di essere docili, di non disturbare, di non smuovere le acque in una situazione squilibrata, ma in maniera più complice, egoistica, per non perdere dei privilegi, e lasciare intatto il sistema di dominazione che riproduce le disparità quotidiane a bassa intensità. Ecco, questo per dire che Kurt invece parla di una tenerezza scelta, politica, dedicata a soggetti oppressi, e, secondo me, il fatto che decida di approfondirla serve molto bene il proposito di differenziarla da quel tipo di docilità, da quel comportarsi in maniera carina ed educata solo per non svegliare l’elemento violento o problematico o la disparità sistemica nel contesto, qualunque sia la forma in cui si presenti.
Rachele - Mentre parlavi mi veniva in mente che Kurt parte dal suo vissuto personale, di una persona di origini turche, la cui famiglia si è trasferita in Germania e che quindi ha vissuto sulla propria pelle, fin da piccola, tutto il razzismo e l'oppressione economica e sociale nel contesto tedesco. Parla spesso di sua madre, la descrive come una persona molto rancorosa, molto rabbiosa, che odia tanto. Ed è un odio che provieve dalla sua condizione nella società, di donna sfruttata per il profitto della nazione. E quell’odio per Kurt è diventato l'unico mezzo per comunicare con la madre. Come hai visto c'è questa specie di ritornello che torna nel testo:
Trovo molto accogliente che la sua prospettiva, la sua idea, sia quella di tendere a una collettività, a una società, a un mondo in cui si possa agire attraverso la comunicazione, la collettivizzazione dei bisogni, dei desideri, dei diritti, anche pensando a un odio generativo, trasformativo se vissuto collettivamente, se non è individuale. Se pensiamo ai momenti in cui proviamo odio nella nostra quotidianità abbiamo questo sentimento anche vendicativo talvolta, di rivalsa, di vendetta, e l'odio individuale è molto pericoloso, le direzioni che prende possono essere anche distruttive per la persona che lo prova e per il contesto di cui fa parte. Mentre quando quest'odio viene collettivizzato, viene messo in qualche posto in cui ci se ne fa qualcosa insieme, può essere effettivamente uno strumento. In questo modo possiamo chiederci che odio è, in che rapporti di potere si trova, e a chi è rivolto. A un certo punto Kurt dice:
E poi rispetto alla repressione, si dice, vabbè, ma perché siete così rabbiose, perché siete così incazzate, in fondo viviamo in una società di pace, di che cosa vi lamentate? Ma quella è la pace di chi vince, la pace di chi opprime, la pace di chi colonizza, la pace di chi ha il potere. Vediamo benissimo che non c'è pace affatto nel mondo in cui viviamo, c'è un genocidio che va avanti da un secolo almeno, guerre e violenze ovunque, una situazione politica mondiale tutt'altro che pacifica, ma ogni volta che si fanno emergere questioni politiche in maniera conflittuale, questo conflitto è sempre respinto al mittente.
Kurt usa questa espressione che mi piace di pace cosmetica, una pace che è solo estetica e non sostanziale. E rispetto all'immagine che usi anche nel tuo libro, della vittima perfetta, Kurt fa un elenco frammentario di casi di persone per cui l'unica risposta possibile nelle loro condizioni era effettivamente l'odio espresso e palese.
Quando si parla di alcuni casi di cronaca, di processi, dalle carte dei processi è sempre come se ci si aspettasse da una persona un comportamento diverso, il fatto che l’oppressa non rinneghi, non abbassi la testa, allora significa che non è vero che subisce un’oppressione.
Giusi - Tu citavi la questione della solitudine dell'odio e di quanto possa essere pericoloso vivere in solitudine l'odio e la rabbia. Mi interessa perché è una delle critiche che viene mossa molto spesso ai temi della giustizia trasformativa: che fine fa la rabbia, che fine fa l'odio? Eppure, se ci facciamo caso, come succede anche nel libro di Kurt e immagino anche nella sua pratica politica, noi stiamo qui a parlare di odio (e di vendetta, di punizione). Stiamo cercando di capire a chi è diretto, ci stiamo facendo tutte queste domande per dargli spazio, inseguendo l’idea che sia utile ricominciare a parlare della componente emotiva delle nostre pratiche, interrogarla, avere canali e possibilità per parlarne senza tabù. L’odio in questa equazione non scompare. «Per dirla con le parole del collettivo LASTESIS:
In Odio si parla anche di call out. Da Instabile avevano pensato a questa parte come uno dei punti di contatto molto forti tra quello di cui mi occupo e Odio. Kurt cita adrienne maree brown e si interroga sulla richiesta che viene fatta sempre all'esterno. Molto spesso mi arriva la domanda: sei pro o contro i call out, e io continuo a dire che possiamo avere una risposta per tutte le situazioni. Ogni caso porta con sé una serie di specificità e non possiamo dire in assoluto se sia o no una pratica negativa, ma il punto interessante è che Kurt ne parla concentrandosi sul desiderio di punire. Forse ci va molto più a fondo, perché ne La trama, ad esempio, io ero molto concentrata a raccontare le pratiche, a raccontare la possibilità, mentre di sicuro c'è ancora bisogno di entrare dentro questa pulsione, di scavare più a fondo. E mi piace quando Kurt dice «vorrei che una delle prime lingue che ho imparato non fosse quella della punizione», cioè riconosce che è così incarnata da essere difficile da decostruire. E l’esperienza di questa ricerca è così complessa, non voglio intendere solo studiarla, ma ricerca anche nel senso di capire dove sta nel nostro corpo, dove si nasconde, di cosa è fatta questa voglia di punire.
Parlando sempre di call out, Kurt si fa tante altre domande:
Kurt scrive, poi, «le culture emotive del tardo capitalismo, le relazioni neoliberali in cui lavoriamo e viviamo esigono sempre l'opposto, nessun conflitto e nessuna negoziazione, ma solo linearità, utilità, accelerazione sulla corsia di sorpasso del successo individuale e collettivo.» È una riflessione che sento molto, nel tipo di educazione politica che abbiamo ricevuto le emozioni non hanno spazio, perché domina una visione maschilista della militanza. Le emozioni vengono sempre lette come segno di debolezza, di vulnerabilità e si teme che esporre questa vulnerabilità all’esterno intaccherebbe nel profondo la nostra azione politica, senza considerare potremmo costruire spazi non necessariamente così esposti. Si perpetuano dei pattern politici che non ci stanno portando molto lontano: i gruppi di ogni tipo si sfaldano in continuazione per mancanza di strumenti per gestire le crisi.
Rachele - Sì, sì, e a volte non sappiamo cosa farne di questa emotività, che può essere un'emotività anche molto esplosiva, in senso distruttivo. In generale il tuo libro, questo libro, il libro di adrienne maree brown, da poco tradotto da Dalla Ridda per Meltemi (Per una giustizia trasformativa) secondo me, pongono questo grande interrogativo, che invece viene riassunto spesso in sei pro o contro la pratica del call out. adrienne maree brown lo dice: Proviamo a vedere come è fatto, come funziona, chi lo fa partire, se sono più persone, se è una persona sola, verso chi è direzionato, a chi è rivolto?
Domande complesse però necessarie perché, di nuovo, se si tratta di una pratica individuale, generata da un individuo isolato, senza una riflessione collettiva, può essere solo distruttivo. È pericoloso per le comunità anche, perché le spezza, le devasta, perché poi la comunità, la collettività si trova a dover gestire un odio totalmente inaspettato, che a volte non era stato nemmeno contestualizzato, espresso in maniera leggibile.
Parlando di call out in sé, a me viene sempre un po' da interrogarmi sulla direzione che ha, se è dall'alto verso il basso, se è dal basso verso l'alto, se è da fuori a dentro, se è dal margine al centro, se è da una collettività verso una persona che ha più potere… le direzioni delle cose, e cioè gli squilibri di potere, mi sembrano sempre importanti e penso che vadano considerati.
E a proposito di individualità e di isolamento, nel tuo libro fai una riflessione sul carcere, su che meccanismi vengono messi in atto e c'è molto la questione dell'isolamento.
Tu dici l'isolamento è isolamento e basta, non ha nessuna potenzialità trasformativa o generativa. In maniera ovviamente estremamente forzata, mi pare di riconoscere delle similarità. Si parla sempre di individui che stanno soli, sole, nella gestione della loro emotività, e l'individualità non ha niente di generativo, fondamentalmente. Anche parlando di conflittualità, spesso si vuole attaccare addosso alle persone politicizzate di sinistra, alle persone che fanno parte di movimenti più radicali, una specie di etichetta di omogeneità, come se la posizione debba essere necessariamente la stessa, perché “siamo tutte dalla stessa parte”. Un tranello che penso venga un po' da una dimensione più esterna, e serve a depotenziare i conflitti e a depotenziare le discussioni conflittuali: di nuovo, non ha nessuna efficacia generativa. Questo ovviamente non significa prendersi a coltellate mentre si parla, anzi, ma il conflitto è importante, il punto è: che cosa ne facciamo del conflitto, come lo prendiamo, come lo plasmiamo, come lo modelliamo secondo quello che pensiamo che ci serva?
Tu dici, avrei dovuto forse mettere di più l'accento sulla legittimazione della rabbia in qualche modo, perché è importante che ci chiediamo cosa ne facciamo di questa rabbia che proviamo e che non va delegittimata. Ma per me la lettura del tuo libro è stata molto calmante in qualche modo, per dire ok, c'è un passo successivo che possiamo provare a fare, possiamo costruire qualcosa che adesso non c'è. Questo mi sembra sempre bello, sia del tuo libro, sia del libro di Kurt, sia dei libri di brown, che anche di altre riflessioni sulla cura, sulla collettività, sul convertire la punizione in trasformazione.
Giusi - Mi vengono in mente di nuovo gli studi sui conflitti, dove abbiamo lavorato molto sulla questione del potere. E anche da gruppi radicali, specialmente di matrice libertaria, c'è molto questa cosa, dobbiamo odiare il potere, il potere è problematico. E lo so che qui mi infilo in grandi questioni politiche da cui non so mai uscire se non con la pratica, però dico… Sì, il potere è problematico, ma cosa del potere è problematico? Lo è il suo abuso, perché in fondo tutt* abbiamo un potere, e io non voglio rinunciare al potere che ho. Quando facciamo finta di non avere potere, o lo ignoriamo, quando crediamo di essere più orizzontali di quanto sia poi vero, allora succedono le cose che citavi: il conflitto viene depotenziato, se non silenziato, alla fine, da chi ha più potere. A questo punto, non è problematico fare finta che il potere non esista?
Per come stiamo impostando il lavoro su questi temi, io credo siano molto importanti l'organizzazione e i ruoli. Riconoscere i ruoli all'interno di una comunità permette anche di non farli ricadere sempre nello stesso punto, anche qui stiamo parlando di potere. E poi… quali sono i ruoli di cui abbiamo bisogno e che magari non ci sono ancora? Ad esempio, tu citi questo ruolo calmante, e mi fa tanto piacere, perché dopo un lungo percorso ho imparato che stare (non sempre e non necessariamente) in quel ruolo, praticarlo, non è, in sostanza, zittire dei bisogni o dei sentimenti, ma capire quando e come io su questi sentimenti ci posso lavorare, proprio in termini di spazio e tempo. Questo l’ho imparato da qualcun altro, è come una trasmissione di saperi. E avere qualcuno che ha aperto per me quello spazio è stato a sua volta calmante per me. Penso poi a quanto reputi io oggi importante e quasi indispensabile il ruolo facilitatore per sostenere una fase autocritica personale e/o di gruppo, avere quei canali, momenti e spazi, per capire dove stiamo andando, di che sentimenti stiamo parlando, con quali intenzioni fondiamo, entriamo o usciamo da un gruppo o partecipiamo a una iniziativa... E questo ruolo rende evidente che ci occupiamo di questioni che si portano con sé cariche emotive pazzesche e a volte attraversiamo quella emotività senza strumenti generativi. Come strumenti a volte esiste un fortissimo linguaggio politico, ma non il linguaggio dell'emozione politica. Faccio un esempio, a volte all'interno di un gruppo si presenta una sofferenza psichica grave (che è anch’essa un ruolo, ok? perché che cosa vuol dire sanità mentale in un panorama così tremendo? davanti al genocidio palestinese, come si fa a rimanere calmi? e quando non posso pagare un affitto, le bollette? soltanto degli esempi…), ma non avere strumenti per prenderci cura di questa sofferenza collettivamente può essere molto pericoloso. Se il gruppo la ignora, va avanti facendo finta di nulla e gestisce le emergenze di volta in volta, se non si è dato mai degli strumenti, dei momenti di studio per capire, se non si è mai parlato di come funziona e di cosa comporta, si rischia di fare dei danni alla persona che porta quella sofferenza e al gruppo. Oppure, quando si continua a ignorare una persona che abusa del suo potere, facendosi bastare le definizioni politiche che il gruppo si è dato a priori, definizioni che a volte diventano lo scudo per non identificare il comportamento problematico, anche lì si possono fare grandi danni che poi si pagano nel tempo.
Rachele - Sì, questa cosa che dici mi fa tanto riflettere, e anche soffrire in parte, perché tante volte ho visto, ho partecipato anche a situazioni di gruppi che si sono sfaldati per questioni di questo tipo, perché non si è riuscite a contestualizzare o a fare una sorta di valutazione della misura delle cose che stavano accadendo nel gruppo, e molto spesso sovrapponendo delle antipatie personali a delle questioni politiche collettive.
Questo è un discorso che io non ho gli strumenti per fare, quindi non lo farò. Sono questioni che leggo, che studio ma mi fanno anche tanta paura, perché non posso dire di essere immune a certi meccanismi.
Giusi - Io penso che sia proprio il principio dire: parto da me perché anche io ho fatto questa cosa. E per quanto sia scontato, non è così frequente. Con questo non voglio dividere le persone in buone e cattive, ma parlare di alcune dinamiche in gruppi di affinità: la difficoltà sta proprio nel pensare di essere immuni e questo diventa uno scoglio enorme per praticare autocritica, e avere spazio e modo per iniziare a confrontarsi. Questo ovviamente non significa soffocare le proprie difficoltà, ma prevedere sia i forse qui potevo fare meglio, che i forse qui invece non si riesce a proseguire perché magari davanti non c’è l’altra metà del lavoro necessario a reincontrarsi. Dinamiche non lavorate provocano malessere, espongono a pericoli, la presa di responsabilità del loro impatto, in certi momenti, sembra remota. E tante manipolazioni di queste pratiche sono possibili, è vero, ma io credo che il tempo sia in grado di raccontarci quando siamo davanti a un lavoro e a uno sforzo reali o davanti a una farsa, a una difesa a uno scudo, questo oltre i risultati, che possono essere insoddisfacento anche dopo grandi sforzi, perché magari mancano capacità e risorse ulteriori.
Tornando a Kurt, è interessante nel suo libro l’uso di questi registri prossimi ai linguaggi della rete (tipo Karl Marx che blocca il suo profilo!) proprio per smorzare il peso dei temi che porta nel discorso. Un po’ come lo shitposting o cose del genere, a volte differenti registri sono in grado di spiegarci le nostre contraddizioni in maniera molto più efficace di qualsiasi lunga e macchinosa teoria politica con un linguaggio ultra farraginoso. Com'è stato tradurre questi cambi di registro?
Rachele - La prima volta che ho visto apparire Karl Marx da Instagram è stato molto divertente. Gli stacchi di registro sono proprio una boccata d'aria, perché le questioni sono molto pesanti e complesse. Quando traduco tendo a immergermi molto, e mi immedesimo nella persona che scrive; seppur ovviamente con dei limiti derivanti dal mio vissuto personale, vivo molto la cosa che traduco e che devo trasferire. Kurt ha la mia età, vive in una nazione che io conosco abbastanza bene, ma il nostro vissuto è differente.
Le cose più difficili da tradurre sono stati alcuni suoni: Hass in tedesco vuol dire odio, e Kurt dice che l'odio sibila. Quando parla dell'odio, ci sono dei momenti in cui usa lunghi periodi in cui si sente tanto la S.
Ora sfoglio a caso le pagine, mi è capitata davanti una parte in cui lei parla del Rojava. Kurt voleva concludere il libro con una visione utopica di tenerezza radicale, di una società tenera possibile. E dice: «Il Rojava è un luogo di nostalgia per noi che abbiamo sete di utopie [...] che desideriamo una società in cui l'odio per l'oppressione possa trasformarsi in una politica comunitaria della tenerezza».
Şeyda Kurt (1992) è nat* a Colonia da una famiglia curda, di origini turche. Il suo lavoro di giornalista e saggista si colloca nella tensione tra marxismo e femminismo queer. Vive tra Colonia e Berlino.
I podcast di Instabile citati all’inizio: